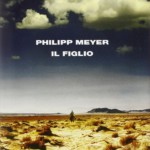L’ultima lezione del Professore. In morte di Umberto Eco
Si è spento nella sua casa, a 84 anni, Umberto Eco. Pare quasi superfluo doverne elencare i meriti, ripercorrere una carriera stratificata, multiforme, che ha attraversato e influenzato non solo la cultura italiana per sei decenni, e per chissà quanti anni a venire. Tra i molti motivi per piangere la scomparsa di uno degli intellettuali italiani più noti nel mondo, probabilmente il più noto, pare difficile riuscire a isolarne uno per tutti, ridurre a emblema un momento di una vita piena di libri, di teorie, di pensieri, di insegnamenti, racconti, lezioni, appunti, battute e polemiche.
Filosofo, laureatosi con una tesi in Estetica su Tommaso d’Aquino, amante e profondo conoscitore del pensiero medievale, ha saputo intercettare come pochi altri lo spirito di tempi a un occhio miope ben diversi da quelli che descrisse in maniera mirabile nel suo clamoroso esordio nel romanzo, Il nome della Rosa. In quella detective story ambientata in un monastero benedettino del Duecento, in filigrana apparve chiaramente come quel Medioevo avesse molto a che fare con una contemporaneità culturale in cui il porto sicuro del realismo era stato definitivamente abbandonato e l’annuncio di un’epoca in cui «nomina nuda tenemus»: l’apparenza sensibile, il gioco linguistico, il nome della rosa emergono come l’unica realtà esperibile, perché poco si potrà ormai dire della cosa in sé, della rosa con le sue spine e i suoi petali.

Il nome della rosa, Jean-Jacques Annaud, 1986
Eco ha annunciato il postmoderno , l’ha sentito arrivare ben prima che le grandi narrazioni mostrassero a tutti le loro crepe profonde. Per tutti gli anni Sessanta – decennio in cui chiude l’esperienza in Rai , è tra le anime dell’ultima avanguardia italiana, il Gruppo ’63 , scrive Opera aperta e La struttura assente che ne certificano lo status di semiologo di rilevanza mondiale, dirige Bompiani e insegna a Torino e Bologna – descrive e interpreta un fermento culturale, sociale e mediatico che solo nel 1979 Lyotard battezzerà come La condizione postmoderna. E proprio nei primi Sessanta arrivano forse i due libri più esemplificativi di quello che era Umberto Eco, quelli che a distanza di cinquant’anni non possono che essere il suo lascito più grande. Due libri che la nostra generazione di scienziati della comunicazione – di cui è padre e nonno, più o meno orgoglioso non lo sapremo mai dovrebbe tenere sempre sul comodino: Diario minimo, 1963 e Apocalittici e integrati, 1964.

Nel secondo di questi, uno dei titoli più citati (ma quanto letti davvero a fondo?) nella vulgata giornalistica, con una serie di saggi di spericolata intelligenza fonda in Italia la critica della cultura di massa, intendendo per critica l’applicazione di strumenti d’interpretazione filosofica a referenti sottovalutati o ignorati dalla cultura alta: i fumetti, il kitsch, la televisione di consumo, la musica pop.
Ma forse è il Diario minimo (e il Il secondo diario minimo, del 1992) il libro che dovremmo correre a rileggere con più attenzione ed entusiasmo. In queste raccolte di scritti di natura disparata, fulminanti analisi, giochi di parole, divertissement, cazzeggi (ci passi il termine, professore), divagazioni, emerge l’Eco più giocoso e irregolare, capace di frequentare con più libertà i limiti del pensiero razionale, di ricorrere al gioco del paradosso e dell’ironia per mettere tra parentesi la sua stessa figura d’istituzione del pensiero italiano (pensiamo al Progetto per una facoltà di irrilevanza comparata), una pratica di destrutturazione patafisica della realtà che rivela altissimi presupposti di moralità del pensiero. Eco inventa la cacopedia: «la pratica di quelle soluzioni che, se uno non si affretta a immaginarle per malvagità e malizia, saranno ben presto immaginate da qualcuno, e sul serio e senza malizia». Non stupisce allora che con tutta la sua intelligenza mai offuscata, negli ultimi anni abbia per la prima volta cominciato ad assumere toni apocalittici.

Immersi in questa post-postmodernità, nel turbine dei significanti, forse contribuendo forse no al così poco sopportato da Eco brusio del luogo comune, in questo giorno di epitaffi, di omaggi, di etichette appiccicate più o meno a proposito, nani sulle spalle del Gigante, tristi come alla morte di un nonno e grati verso chi ha, senza mezzi termini, contribuito in maniera decisiva alla quota di intelligenza come «fenomeno collettivo, nazionale, intermittente» di questo Paese, ci consoliamo pensando che il professor Eco avrebbe usato il suo grimaldello filosofico preferito, una bella risata:
[…] perché l’Ordine o lo si ride dal di dentro o lo si bestemmia dal di fuori; o si finge di accettarlo per farlo esplodere, o si finge di rifiutarlo per farlo rifiorire in altre forme; o si è Rabelais o si è Cartesio; o si è, come Franti ha tentato, uno scolaro che ride in scuola, o un analfabeta di avanguardia (Elogio di Franti, in Il secondo diario minimo, Bompiani 1992)