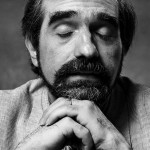Quel Bravo Ragazzo di Jordan Belfort
Perché The Wolf of Wall Street è uno dei film più decisivi di questi anni
«La mafia non è un’estranea in questo mondo: ci si trova perfettamente a suo agio. Nell’epoca dello spettacolare integrato, essa appare di fatto come il modello di tutte le imprese commerciali avanzate», Guy Debord nei Commentari sulla società dello spettacolo del 1988 diceva che in fondo mafia e grande capitalismo funzionano allo stesso modo. Negli stessi anni Henry Hill, interpretato sullo schermo da Ray Liotta in Quei bravi ragazzi di Scorsese diceva: «Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster». Gli anni in cui si apriva la parabola di Jordan Belfort, il broker che, disoccupato dopo il crollo azionario del 1987, stava per diventare il Lupo di Wall Street vendendo azioni spazzatura a migliaia di piccoli investitori.
The Wolf of Wall Street forse sta tutto qui. Dopo la confessione del goodfella Henry Hill Scorsese filma un’altra confessione-fiume, un altro viaggio forsennato e imprescindibile, antropologico e stupefatto, in un mondo in cui la violenza darwiniana della vita contemporanea appare in tutta la sua potente evidenza. Ma se in Quei bravi ragazzi lo spettatore più superficiale poteva muoversi rassicurato dalla distanza temporale, e morale, che intercorreva con un gangster newyorkese degli anni Sessanta, in The Wolf of Wall Street la faccenda si fa più complessa, la poltrona più scomoda, l’interrogazione più radicale.

Scorsese mischia le carte, come in Shutter Island getta lo spettatore in una posizione ambigua rispetto alla storia. Qual è la versione di Jordan e quale quella di Martin? La confessione è in prima persona: Leonardo Di Caprio magnetico prende il centro della scena, guarda in macchina e ci guida nella sua storia; mostra la sua iniziazione alla religione del profitto; ammiccante ci trascina nel carnevale di eccessi della sua vita; assistiamo dall’interno alla sua caduta la cui mancata fragorosità inquieta i moralismi da oratorio. Ma la macchina da presa di Scorsese contesta e sgambetta il protagonista, le soggettive sono false, il punto di vista è in continuo slittamento, la verità delle immagini è un miraggio, ogni inquadratura racconta un aspetto possibile, virtuale, della stessa storia.
La virtualità è la cifra assoluta della finanza. La finanza è la cifra assoluta della contemporaneità. La mafia è la cifra assoluta della finanza. Henry Hill e Jordan Belfort sono fratelli, ma quest’ultimo non necessita della violenza, ha capito che la costruzione, virtuale, di un bisogno crea astronomici tornaconti reali. Non c’è altro che freddo accumulo: di donne c’è il sesso ma non c’è l’erotismo, l’unica scena sexy del film è un gioco di potere, non di seduzione , di droghe, di esperienze privilegiate, di oggetti. Belfort non vende cose, vende ambizioni. E Scorsese in un ultimo movimento di macchina, questo sì profondamente etico, mostra il controcampo, quella massa percorsa dalla stessa ambizione di unicità e distinzione attraverso la ricchezza e noi, di fronte allo schermo diventato specchio, lo capiamo: Jordan Belfort è un virus da cui siamo già stati uccisi.