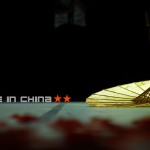C’è una parola che negli ultimi cinquanta-sessant’anni si è imposta nella vita di tutti i giorni come fosse un vocabolo irrinunciabile per parlare del nostro mondo. È una parola piccola, semplicissima, tre lettere appena, un palindromo prêt-à-porter cui nessuno sa più rinunciare: alzi la mano, però, chi sa veramente cosa vuol dire pop. O meglio, chi sa cosa vuole dire, quando dice pop. Simone Perinelli – memoria permettendo – quella parola non la pronuncia mai, ma riesce a costruirvi su uno spettacolo di raro equilibrio. Forse però, prima, vale la pena sfatare qualche falso mito.
Innanzitutto. Il pop non è un genere, a meno che anche la generosità o l’oppressione, per dire, vengano considerati tali. Il pop, poi, non è neanche un gusto, né tantomeno una scelta, il pop è piuttosto un’omertà dell’individuo, un silenzio assenso, un’adesione involontaria e inconsapevole a qualcosa. Pop insomma è ciò che unisce tutti, o poco meno, senza che nessuno se ne accorga, senza che quei tutti si sentano una collettività. Il compiaciuto cinismo è pop, la parola democrazia è pop, il denaro è pop. A non essere per niente pop, invece, è Pinocchio: egli mente, disobbedisce, scappa, ma soprattutto sbaglia e scopre di aver sbagliato.
Sulla scena di Centrale Preneste Teatro, ad accoglierci, c’è un Pinocchio cresciuto: finalmente umano, infine uomo. Niente più avventure rocambolesche per lui, neanche più una bugia, ci sono già gli altri a mentire, a farlo nella vita vera; tanto che tutto il suo instancabile entusiasmo, d’un tratto, appare come uno scatto nervoso, inquietantemente scricchiolante, del legno cui vuole tornare: il Pinocchio di LeVieDelFool, infatti, è sfiancato dalla lotta alla sopravvivenza nella società, vuole tornare marionetta. Eccolo allora di nuovo alla sbarra, a raccontare un’altra fiaba. Di fronte a sé un microfono, alle sue spalle un tavolo, e da questo una fune che pende; così, già in questa scena essenziale, ci appare tutto il dramma della sua umanità: lui che era una marionetta senza fili si ritrova adesso preso al laccio da una vita che non gli appartiene.
Nel suo racconto-apologia allora ritornano le tappe della celebre storia, la fuga dagli assassini, l’incontro con la Fata, il paese dei balocchi, Geppetto nella balena, ora però tutto si fa più pesante, zavorrato dall’esperienza fittizia del vivere in società: egli si destreggia tra slogan pubblicitari, luoghi comuni, citazioni pseudoculturali, incombenze economiche, meschinità gratuite, un terreno melmoso che imbratta la spensieratezza del pupazzo di legno e risputa sulla riva della quotidianità un pezzo d’uomo tutto tarlato. E la palude limacciosa su cui si costruisce la nuova storia di questo picaro invecchiato è proprio il blob contagioso del pop: un fango che invischia e infine corrompe.
Perché tesaurizziamo lusinghe e insulti, ferite e affetto? Senza questo accumulo di esperienze e delle loro reazioni noi non esistiamo; non siamo nulla se non abbiamo nome, affetti, credenze. È la paura di essere nulla che ci spinge ad accumulare; ed è questa stessa paura, conscia o inconscia che sia, che, nonostante le nostre attività cumulative, provoca la nostra disintegrazione, la nostra distruzione. Se possiamo renderci conto della verità di questa paura, allora è la verità che ci libera di essa, e non la nostra risoluta determinazione di essere liberi.
Come recitano le parole di Krishnamurti, infatti, ciò che colpisce di più di Requiem for Pinocchio non è tanto il sorprendente funambolismo fra le iperboli pop né la magnetica prova d’attore di Perinelli (anche regista e autore), ma l’estremo equilibrio – nell’eccesso – della denuncia: contrariamente a non poco teatro contemporaneo, ancora vittima di retoriche e nostalgie da presunto impegno civile made in “la sinistra di una volta”, lo spettacolo di LeVieDelFool rinuncia all’invettiva astiosa per comporre – omen nomen – un requiem che si fa arte della costernazione, ironia tragica, autocondanna prima che condanna, accettazione insomma della propria incompatibilità. Questo Pinocchio, dunque, non punta il dito alla società, non le grida che deve cambiare: fa piuttosto un’alzata di spalle, sospira, e con una gran pena negli occhi ci dice che no, proprio non ce la fa a essere uomo in questo mondo.
Ascolto consigliato
Centrale Preneste Teatro, Roma – 7 febbraio 2015
In apertura di scena: Foto di ©Guido Mencari