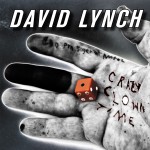Una prolungata inattività da parte di un gruppo musicale può voler dire due cose: perdita della vena creativa o ricerca di un miglioramento stilistico. L’ultimo caso è quello che ci interessa: dopo dodici anni dall’ultimo disco in studio, i Portishead aprono le cigolanti porte degli scantinati di Bristol, la cittadina inglese che ha generato, cullato e fatto crescere fra nebbiosi moli e industrie tessili il genere trip-hop. Il disco è pervaso da beat elettronici e campionamenti ossessivi e a tratti teutonici, chitarre sommessamente incattivite e oniricamente arpeggianti, ricercatezza nell’ uso di effetti ambient, ritmiche che sfiorano sonorità tribali (Silence) per passare repentinamente a cadenze folk anni ’40 (Deep Water).
Il comune denominatore, conciliatore di questo eclettismo musicale multiforme, è l’eterea voce di Beth Gibbons, impalpabile e allo stesso tempo inconfondibile marchio di fabbrica del gruppo: voce sbattuta dalla crudezza forsennata di We Carry On, cupamente protagonista di Hunter, sognante in The Rip, che accompagna flebilmente per mano una batteria elettronica impazzita in Machine Gun.
Le direttive musicali e liriche di quest’album, cupezza e disillusione nei confronti di un mondo plastico pongono tutte le premesse per pensare di trovarci di fronte ad uno degli album migliori dell’appena trascorso 2008.