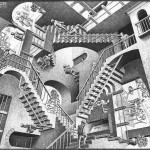L’intruso – Davide Tassi | Francesca Rizzi
Io sono una persona sgradevole: è una dichiarazione d’intenti ben precisa quella di Davide Tassi. Egli entra in scena, solo una sedia come ausilio al suo racconto, e in tono solenne annuncia al pubblico che questa è la confessione di un uomo di non buone maniere. Una storia intima, a volte dolorosa e dai risvolti scomodi, che noi, pubblico, avremo il compito di ascoltare e giudicare. È questa la premessa per L’intruso, monologo scritto e interpretato da Tassi stesso, per la regia di Francesca Rizzi (selezionato dalla redazione del webzine Teatro e Critica per la rassegna interna del Roma Fringe Festival “il meglio della «scena romana» indipendente”).
Ma ora veniamo allo spettacolo. Il protagonista senza nome di cui l’attore prende i panni è un uomo comune, svolge un lavoro d’ufficio alienante e sterile in un ambiente aziendale che, sotto un apparente buonismo da self-improvement, cela disumanità e indifferenza. Così, l’unica evasione per lui consiste nel guardare le vite degli altri, osservarle con precisione chirurgica fino a spiarne i momenti più privati quelli in cui pensiamo di non essere visti in modo da poter smascherare comportamenti umani che si rivelano falsi e ipocriti. Ecco allora che emergono i profili dei vicini di ufficio, il collega raccomandato e il vicino di casa, simbolo di una borghesia ingorda e opulenta. Ma l’osservazione delle vite degli altri non fa altro che rendere più visibile la propria incapacità ad agire, poiché, se da un lato il protagonista fa tabula rasa della realtà attorno a sé, dall’altro è incapace di costruire, e rimane così in una voragine di spaventosa solitudine.
C’è un po’ dell’inettitudine dei personaggi di Pessoa, un po’ dell’invettiva alla Pasolini nei confronti di una società che nasconde i suoi istinti più bassi dietro un tappeto di finto perbenismo e, infine, un po’ dell’atmosfera tipica di Pirandello quando si indaga quello scarto intrinseco fra apparenza e realtà che ci espone a molteplici identità. Il tutto condito da una rabbia inquieta insita in ogni parola, costruita su un italiano colto che sembra uscito dalle pagine di un bel romanzo; e proprio questa rabbia si trasmette presto alla fisicità nervosa e convulsa di Tassi: egli si tormenta le nocche, sta seduto ma mai comodo, poi si alza repentino preso da un pensiero improvviso e si rivolge al pubblico, rendendolo partecipe di tutto il marcio della sua vita.
E una storia così, certo, non può avere un lieto fine, e forse è questa la parte più debole della drammaturgia, che compie un salto eccessivo verso situazioni scabrose minando la credibilità del racconto (come la violenza sessuale su una minore e gli otto anni di carcere che ne conseguono, i più belli della mia vita). Ma è una nota a margine, poiché l’introspezione psicologica di cui il testo di Tassi si fa carico affonda senza inibizioni nel mondo oscuro dell’inconscio, in tutta la sua impietosa lucidità, nell’amara constatazione che a volte l’intelligenza può diventare paralizzante proprio perché rende eccessivamente consapevoli.
Proprio come afferma Bernardo Soares nel Libro dell’Inquietudine: l’intelligenza astratta è un peso della consapevolezza del mondo, una impossibilità di respirare con l’anima.
(Foto ©Emanuela Bauco)