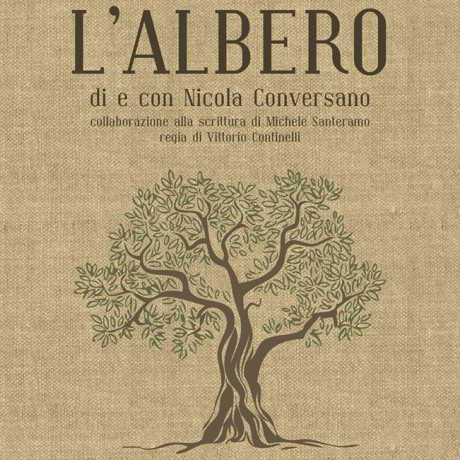Furia Avicola – Rafael Spregelburd | Manuela Cherubini
Le misure non servono a niente, se quelli che misurano non sono d’accordo.
Si potrebbe partire da qui per avventurarsi in Furia Avicola, da una manciata di parole in italiano stentato ma di adamantina incisività, da un modesto padre portoghese che sgrana il suo corollario alla fine di un’interminabile disquisizione, tra due docenti di arte e la figlia bocciata, a proposito dell’argomento: può il restauro tragicamente disastroso di un quadro essere considerato opera d’arte? Sembra complicato, ma già in questa domanda e in quella risposta, l’argentino Rafael Spregelburd ci offre tutti i mezzi per imbarcarci in un viaggio, strampalato solo in apparenza, alla scoperta del più sconclusionato dei mondi possibili – il nostro.
E difatti basterebbe anche già il titolo, Furia Avicola (regia di Spregelburd e Manuela Cherubini, anche traduttrice), accoppiata bizzarra che in un sol colpo prende al laccio due grandi recenti fenomeni di massa: il terrore dell’aviaria e il popolare videogioco Angry Birds – un po’ come dire nel 2015 Ebola e Candy Crush -, due fenomeni che da un giorno all’altro catalizzano l’attenzione planetaria non tanto per la loro importanza intrinseca, ma per quell’improvvisa(ta) capacità di far parlare di sé, di circolare da una parte all’altra del globo senza una precisa ragione, senza la volontà consapevole da parte dei suoi agenti – “la gente” – di trasmettere alcunché.
Ecco allora che torna alla mente l’eterna questione di cosa sia davvero un’opera d’arte (leggi “il senso della vita”), di chi possa concepirla, recepirla e diffonderla come tale. Come suggerisce Massimo Marino su Doppiozero (leggi qui), torna alla mente l’incubo degli uccelli di Hitchcock, ma tornano altresì gli effimeri tweet moderni e si possono riscontrare altrettante curiose analogie – perfino nel titolo – con l’ultimo film di Iñarritu – Birdman -, in cui riemergono per l’appunto le contraddizioni di valore e viralità, canone e popolarità, misura e giudizio, volontà e visibilità.
Ed è curioso che a ricorrere come sorta di correlativo oggettivo di questa pasticciata e posticcia post-postmodernità sia sempre un volatile: che tenga sotto terrore il mondo, che si schianti contro un muro per intrattenimento, che veicoli i sentimenti in dubbie pillole di 140 caratteri, o che giaccia alla spalle come ombra ominosa sul presente, ritroviamo uno dei simbolo arcaici per eccellenza, fenice imbarbarita di una contemporaneità che vorrebbe ma non sa come risorgere, perché stenta a capire se sia già morta o se debba ancora finire di agonizzare – mentre in realtà ha solo bisogno di crescere.
Così, con gusto tutto kafkiano, la seconda parte di Furia Avicola ci accompagna nell’altra faccia di quel volo mancato: la burocrazia, il sottosuolo dell’ordine impossibile, il regno di nessuno in cui ogni pensiero, desiderio o aspirazione finisce per vorticare senza esito alcuno nel grande circolo vizioso di un’organizzazione avvitata su se stessa – l’organizzazione dell’organizzazione -: le cose valgono, non valgono, si svalutano, si rivalutano, si rifiutano al valore. Una voragine di sentimenti inutili, dove il movimento è solo apparente, contrappasso di quell’aspirazione alla libertà che si traduce, appunto, soltanto in segni mortiferi – l’aviaria, il restauro disastroso, gli uffici andati a fuoco – o distruttivi – angry birds, gli archivi buttati, il denaro bruciato -.
Tratto fondamentale di questo spassoso, irriverente e acutissimo sguardo sul mondo, allora, non può che essere l’assurdo: assurdo che nella sua commistione di nonsense ed esilarante tragicità segna il dramma tutto contemporaneo di una società che vuole storicizzarsi, criticarsi, psicoanalizzarsi (tutti termini tipicamente otto-novecenteschi) senza neanche aver imparato a osservarsi, a lasciarsi il tempo di capire chi sia e cosa voglia; affidandosi, piuttosto, al baluginio di fuochi di paglia che per qualche istante sembrano divampare ovunque, rigor mortis di una “collettività alienata”, per poi lasciare tutti quanti soli, depressi e storditi, come uccelli lanciati contro un muro digitale. E solo perché qualcuno aveva parlato di volare.
Teatro India, Roma – 17 febbraio 2015
In apertura: Foto di scena ©Giovanni Chiarot)