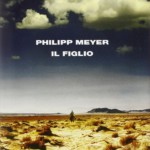In morte di un romanziere
Era la sera del 12 settembre 2008 quando David Foster Wallace veniva trovato morto dalla moglie, impiccato nel patio della sua casa di Claremont. Aveva solo quarantasei anni. In questi anni senza David è successa una cosa prevedibile quanto a tratti stucchevole. La sua presenza nella cultura occidentale pare essere ingigantita. A cominciare dall’Italia, dove da autore di culto quanto di nicchia, tradotto dalla seminale attività di una casa editrice indipendente come Minimum Fax, è passato a essere nome irrinunciabile nella chiacchiera intellettuale, forse più citato che letto, mentre sono apparsi via via nuovi suoi inediti, dai brevi testi di Questa è l’acqua all’incompiuto romanzo Il re pallido fino alla raccolta di saggi Di carne e di nulla, evento editoriale targato Einaudi per il quinto anniversario della scomparsa.
L’eco del suo suicidio, termine di almeno vent’anni vissuti convivendo con una grave forma di depressione, e la fortuna mondiale postuma che ne è seguita non sarebbero stati così significativi se non ci trovassimo di fronte all’opera di uno dei pochissimi individui per cui non è gratuito e stucchevole spendere la parola genio. David Foster Wallace è, a oggi, una delle menti del secolo. La sua infinita ed enciclopedica cultura, la sua ironia, il suo talento narrativo, la sua empatia verso le storie e i personaggi, la sua sterminata produzione che attraversa, rimanendo sempre uguale a se stessa, i generi, dal romanzo al racconto in ogni sua forma, dalla saggistica alla recensione e al reportage, continuano a descrivere, con adamantina e immediata evidenza, la nostra vita.

Sarebbe verboso e fuori luogo elencare qui quanto grande è stata la lungimiranza e la forza evocativa dell’opera di Wallace alla luce della post-postmodernità in cui siamo immersi. Basti citare la sua opera più grande, Infinite Jest, del 1996, un arciromanzo tentacolare e immenso ambientato in un futuro prossimo in cui gli anni del calendario prendono il nome di uno sponsor e in cui i personaggi si affannano dietro la droga perfetta: un film che ti incolla davanti a uno schermo esaurendo ogni tuo bisogno, fino a quando ti lasci morire, assuefatto e completato dalla sostituzione della vita con la rappresentazione. Basti dire che il suo terzo e incompiuto romanzo maggiore, Il re pallido ha (avrebbe avuto) al centro la noia come estrema e totalizzante esperienza esistenziale della modernità.
Il 12 settembre 2008 abbiamo perso un romanziere. Uso questo termine come omaggio assoluto e non come riduzione. David Foster Wallace era uno degli ultimi e dei pochi ad avere ancora dentro quella forza di pensiero, quel respiro lungo che avevano i grandi romanzieri modernisti, ad essere collocabile nella tradizione maggiore del Romanzo come prodotto precipuo e più grande della cultura dei Tempi moderni nell’Occidente. Coloro che ne parlano, non del tutto a torto ma in maniera riduttiva, come di un alfiere del postmodernismo, non ne intuiscono la portata rivoluzionaria quanto antimoderna: non è (solo) a Pynchon e Burroughs che bisogna ricondurlo, ma a Rabelais e Diderot, a Dostoevskij e Flaubert, a Kafka e Musil. Da anni piangiamo un, per usare una definizione kunderiana, modernista antimoderno, l’ultimo eroe di quell’avventura del pensiero che è stata il Romanzo, uno degli ultimi a portarci in quel luogo in cui «nessuno possiede la verità e in cui ciascuno ha diritto ad essere capito» (Milan Kundera, L’arte del Romanzo).