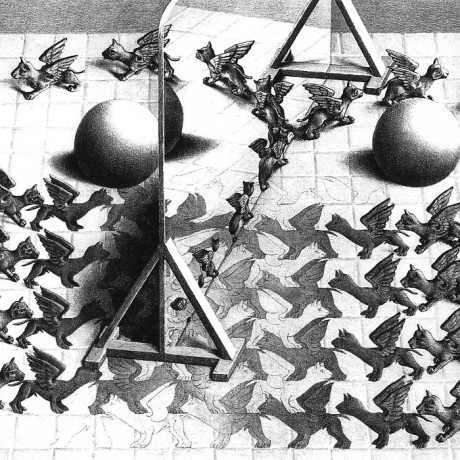Come rispondere alla crisi
AltoFest e la buona pratica dell'irregolarità
Come erano belli gli anni Sessanta! L‘avanguardia, la ricerca, le cantine romane! Quanto fermento! Quanta creazione! Nevvero, caro lettore? Così almeno recita la vulgata. E noi vogliamo crederci. Ma a sentire chi quegli anni li ha vissuti (e però non è riuscito o non si è interessato di porre fondamenta abbastanza durevoli), c’è un fattore che fece la differenza: il senso della comunità. Non tanto nella sua accezione utopico-socialista, quanto piuttosto nel senso più pratico e concreto di scambio, apertura, collaborazione.
Ora gli artisti viaggiano molto più che prima, fanno seminari e laboratori, si incontrano, lavorano a progetti internazionali, eppure non si avverte la stessa sensazione che si narra ci fosse cinquant’anni fa. Sì, certo, qualche sconfinamento c’è – viene in mente il Kaspar Hauser di Manuli, ad esempio –, si possono tracciare mappe di tendenze generali, percorsi intrecciati, questioni ricorrenti, ma niente che lasci intuire un movimento comune. C’è grande frammentazione. Anche ai festival più validi si ha un po’ la sensazione della vetrina: sfilano sul palco gli artisti, ognuno porta in scena la propria creazione, magari qualche collaborazione, però ciascuno poi dritto per la sua strada.
Palazzo Sanfelice, Rione Sanità. Foto ©Lucio Criscuolo
Ora. Lo scorso finesettimana a Napoli mentre numerosi critici italiani si affollavano attorno al discusso Napoli Teatro Festival (circa 200 mila euro solo per le dodici repliche al Politeama, riporta Il Mattino), quegli irregolari di Anna Gesualdi e Giovanni Trono – in arte TeatrInGestazione – attraversavano la città con il loro AltoFest nel totale silenzio stampa (non un solo giornalista). Dalla scalinata della Pedementina al rione Sanità, passando di qua e di là di Spaccanapoli fra vie, case private, palazzi settecenteschi, acquedotti sotterranei, cave di tufo, negozi e locali, la coppia pugliese di origine ma napoletana di adozione offriva alla città da mattina a sera in maniera totalmente gratuita e autofinanziata (con un budget che farebbe impallidire anche una compagnia alla prima produzione) performance, spettacoli, concerti e installazioni di artisti provenienti da tutta Europa.
Pedementina. Foto #PeopleOfAltoFest
Miracolo? Rivoluzione? No, assolutamente: dicesi determinazione, perseveranza, volontà. Anche qui in fondo ritorna la fragilità creativa di questa lunga era di eterno «post…ismo» o «post-post…ismo»; anche qui le giovani realtà che accendono i quattro giorni dell’AltoFest spesso ripropongono una sperimentazione già esplorata trenta, quaranta, cinquant’anni fa senza magari neanche saperlo (leggi qui); ciononostante, qui c’è qualcosa che fa davvero la differenza, ed è proprio lo spirito della comunità.
Foto ©Lucio Criscuolo
La «gente» di Napoli – e usiamo volontariamente una parola tanto suscettibile di genericità – si offre spontaneamente, senza averne nulla in cambio: una via di quartiere, un appartamento privato, il retrobottega, si fanno tutti luogo di condivisione, spazio in cui si accoglie e si osserva insieme, in cui si beve un tè freddo, si fuma una sigaretta, si esprime entusiasmo o perplessità, insomma, in cui la gente – senza timore d’ignoranza o timidezza – si incontra. Ciascuno “diventa parte” attiva. Non a caso il sottotitolo dell’Alto Fest è proprio «Dare Luogo».
Foto ©Lucio Criscuolo
E a ogni performance le domande che vengono sollevate, infatti, sono domande chiare: cos’è l’amore? qual è il tuo luogo? cosa ti aspetti? cosa vuoi vedere? cosa pensi? Si ritorna a quesiti comuni, immediati, universali, a quegli interrogativi che – declinati secondo il proprio contesto – ognuno si pone. E questo è fondamentale, riattiva il senso di comunanza, di contiguità.
Gesualdi-Trono, gli artisti, lo staff e chiunque altri ruoti attorno all’AltoFest giocano tutti a perdere. Lo sanno. Lo accettano. E proprio per questo ci investono. Quasi a ricordare, tacitamente, che non è certo il denaro a dettare il valore; che il lavoro non è tale solo se viene retribuito; che il compromesso può dirsi tale se significa “farsi incontro”, altrimenti è solo resa opportunista. Concetti non nuovi, certo, ma che al momento del dunque troppo spesso tendiamo a dimenticare. O come chiosava acutamente Trilussa in un libro di poesie che troviamo nella casa in cui siamo stati ospitati:
«Nun capisco mai, quanno m‘inchino,
Se me piego davero o se m‘adatto.»
[da L’indecisi]
Areoporto di Napoli. Foto #PeopleOfAltoFest
Con Alto Fest, dunque, Gesualdi-Trono dimostrano che c’è un’alternativa allo status quo dei finanziamenti statali, degli scambi, delle produzioni a ranghi serrati; che l’arte, o ancor meglio, che la curiosità e la creatività innanzitutto si coltivano, non si innestano a forza con bandi e iniezioni di denaro; insomma, che se il teatro deve essere solo un sollazzo “standardizzato” per pochi (pochi e benestanti), se ne può fare anche a meno.
Le famose cantine romane di cui sopra, dopotutto, nacquero dalla volontà, dall’esigenza, dalla vocazione, non aspettavano certo decreti ministeriali o sentenze del tribunale. Come scriveva Giuseppe Bartolucci:
Nelle cantine […] il vecchio teatro era colpito al cuore, e la sua tradizione era divorata e fatta a brandelli, il suo conformismo era sbandierato dappertutto a pubblica vergogna e inettitudine. […] Dentro le cantine si lottava a morte con se stessi, per rifondare il linguaggio teatrale, per ridargli tonalità moderna, per estirpare la provincialità del teatro di cultura, per trasformare le istituzioni stesse a tagli di genialità.
Foto ©Lucio Criscuolo
AltoFest non è certo la cantina romana del XXI secolo ma senz’altro è molto più che un «festival» e rappresenta un felice esempio di irregolarità che dovrebbe spingere molti commentatori a riflettere (così come il caso emblematico, sempre inspiegabilmente “non considerato”, di RezzaMastrella). Che in questo Paese, poi, ci sia bisogno di una riforma ragionata del teatro, di un censimento ponderato e di una seria politica culturale che valorizzi il patrimonio performativo “vivente” è indubbio. Ma nel frattempo nessuno deve confondere «volere» con «potere», «non potere» con «non fare».
Palazzo San Felice, Rione Sanità. Foto #PeopleOfAltoFest
Ad ogni modo. Se Gesualdi-Trono desiderano che la loro azione germini ulteriormente bisognerà che quella voce, encomiabile, che recita «dare luogo» presto o tardi evolva in “lasciare traccia”.
Ascolto consigliato
Napoli – 1, 2 e 3 luglio 2016