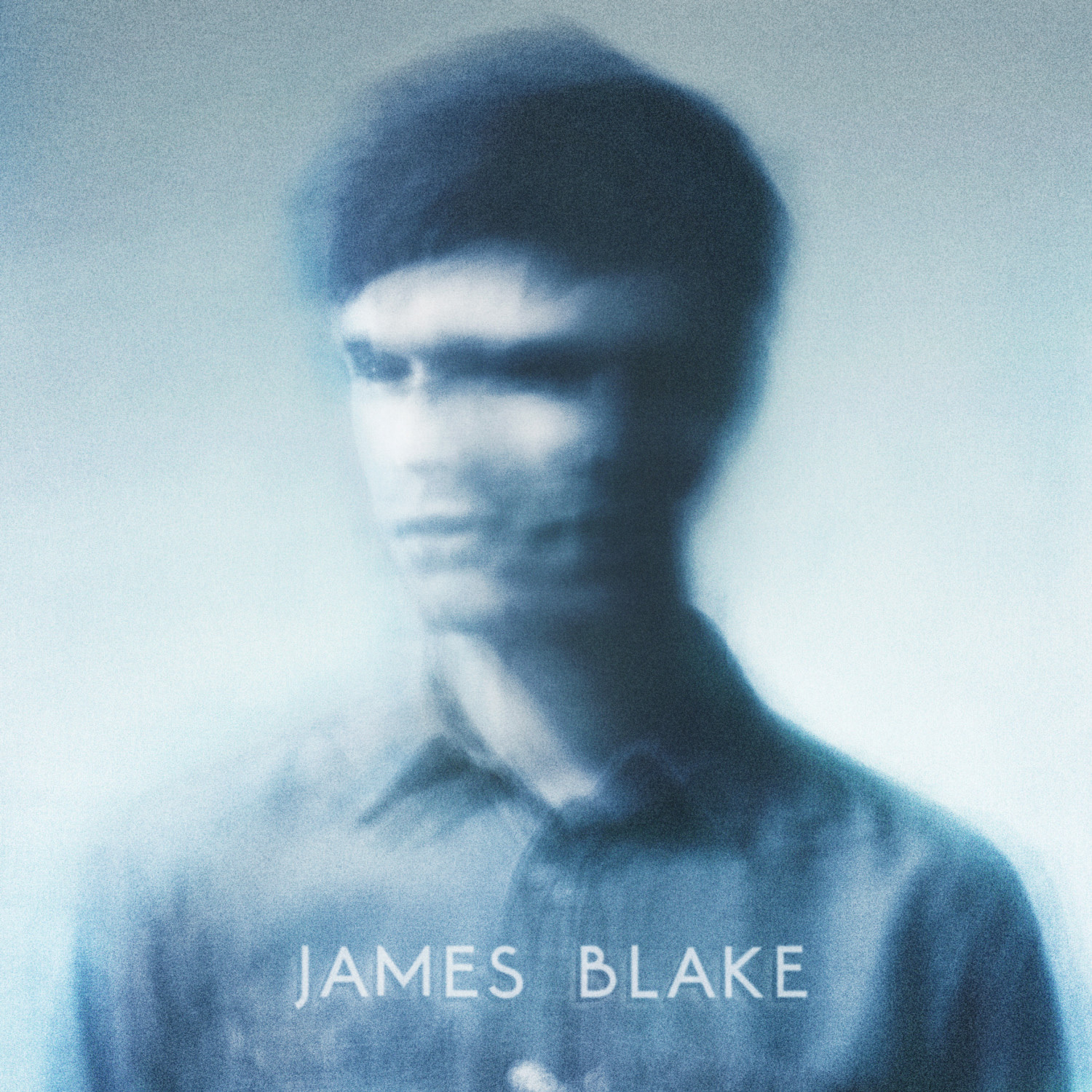È notte, fuori sta piovigginando, le nuvole si muovono veloci ma l'atmosfera è apparentemente statica, ho un forte peso al petto e questo James Blake mi alleggerisce.
Qui da noi in Italia si fa fatica a concepire, non tanto che un giovane ventiduenne possa diventare la rivelazione del 2011, anche noi a nostro modo abbiamo giovani validi nella musica. Ma diventare una promessa della musica UK e non solo portando a picchi di visibilità il dubstep come a metà degli anni zero segnati da Burial (ma anche Skream), ricaratterizzandolo in modo personale non è cosa da pochi. Se poi la BBC ti inserisce al secondo posto del suo personale elenco delle promesse del 2011 Sounds of 2011, allora forse non è il classico caso fomentato da tanto hype e poca sostanza. Qui di sostanza ne troviamo (molta post-prodotta) suono dopo suono, minuto dopo minuto, brano dopo brano.
Vi chiedevate cos’è il dubstep? Me lo sono chiesto anche io senza vergognarmi di ciò. Non è vietato chiedere da cosa sia caratterizzato un genere, anzi molti pensano di saperlo ma quando poi ci provano a spiegarlo allora le cose diventano difficili.
Partiamo dalla dance elettronica dalla quale si sviluppa la UK Garage di fine anni '90 che però arriva a sua volta dagli Usa dove il Paradise Garage è il locale newyorkese simbolo della nascente scena americana garage-house. In UK Armand Van Helden è il maggior esponente nella night clubbing londinese. Quindi per farvi paragone non forzato Londra sta alla UK Garage e derivati come Bristol sta al trip-hop.
Come è normale che sia, questo genere non rimane immutato ma si diversifica, assorbe influenze molteplici, quindi tutto il post-UK Garage si divide in tante piccole nicchie musicali (broken beat, Uk funky, dubstep o grime o ancora bassline) differenti l’una dall'altra. Ma il dubstep è definito anche dai ritmi claudicanti e sincopati del 2step (che appunto abbandona il classico 4/4), più semplicemente gli Artful Dodger (ve li ricorderete soprattutto nella collaborazione con Craig David in Re Rewind – 1999) definirono il 2step come una forma di dance che suona a metà fra Stevie Wonder, Quincy Jones e il suono dei club underground. Infine metteteci elementi del dub (per farla breve un reggae spogliato di voci, alzato di ritmica ed effettato) e avrete un'idea ancora non definitiva ma piuttosto esaustiva.
L'inglesino con la faccia un po' pulita e un po' da schiaffi è cantante, dj e produttore con all'attivo tre Ep (The Bells Sketch, CMYK e Klavierwerke), ma solo nell'ultimo si iniziano a sentire le evoluzioni stilistiche presenti in questo suo primo lavoro sulla lunga distanza. Blake va oltre il dubstep, si potrebbe parlare di post-dubstep influenzato fortemente dagli XX e più precisamente dai loro beat minimali realizzati da Jamie Smith (Jamie XX), elemento connotativo della band.
Ma sotto c'è molto di più e se fuori pioviggina leggermente appena parte Unluck ho anche il sonoro di questo clima nelle mie orecchie. Sento i tuoni elettronici in lontananza e se guardo fuori sono in perfetta sintonia coi bagliori notturni del cielo, sincronizzati alla perfezione. Flussi ben distinti con lampi di R'n'B che scorrono su linee rotte, alternandosi all’anima soul della voce del giovane Blake con un piano che diventa sempre più sintetico, come la voce che mano a mano perde calore, si moltiplica e si satura come l’aria pesante che respiro fuori dal mio balcone stanotte.
Intanto il beat di fondo delle piccolissime gocce elettroniche continua a ornare questo clima austero riempiendo gli spazi vuoti e creandone altri.
Wilhem Scream parte con l'anima lamentosa, ma non melodrammatica, simile a quella di Anthony Hegarty (Anthony and the Johnsons), dove le somiglianze vocali si percepiscono prendendo poi percorsi differenti. Questa continua caduta della voce porta James ad essere assorbito e avvolto lui stesso dalla sua creatura.
(I don’t know about my dreams /I don’t know about my dreamin anymore./ All that I know is / I’m fallin, fallin, fallin, fallin. / Fallin)
Intima e solitaria parte I Never Learnt to Share poi muta, cresce si sviluppa diventando ansiogena in chiusura grazie ai synth e ai pattern elettronici.
La capacità di gestire gli spazi sonori è matura e meticolosa; fondamentali più del suonato sono le pause, che Miles Davis era maestro nell'utilizzare alla stessa maniera pur se in ambito diverso, enfatizzando il suonato, grazie alla suspense della pausa – un po’ come quando vi succede guardando il cielo, vedete il fulmine illuminare la notte, poi la pausa e poi il tuono fragoroso ancora più forte di quello che vi sareste aspettati, amplificato dal silenzio precedente -. Lindesfarne I parte così, piena di sospensioni vocali dove si gioca manipolando all’estremo, decostruendone la struttura in modo marcato e ricostruendola a suo modo come solo l’architettura di Daniel Libeskind potrebbe renderne un’idea visibile. Il giocare per sottrazione, viene poi smentito quando si riempiono i tratti vuoti portandovi una pace interiore persa prima e riacquisita in Lindesfarne II.
In mezzo come se fosse una pietra preziosa scoperta per caso, spunta la cover di Limit To Your Love di Feist che irrorerà i vostri sensi facendovi dimenticare l'originale dopo pochi ascolti, dove fanno staffetta voce leggera a passi alternati col piano e periodi sonici di bassi dubstep in contrapposizione esaltata.
Give Me My Moth e Why Don’t You Call Me tornano alla forma canzone più classica, dolente e sincera, sussurrando i propri pensieri. To Care Like You è rarefatta di ritmi dubstep e voci alternate affannate mentre I Mind resta sempre sulla sottile linea tra la pace suprema e l’angoscia bisbigliata accompagnata da un beat intraprendente ma non forzato. Arriviamo al mattino quando la luce del sole non ha ancora deciso di palesarsi ma il clima solenne di Measurements caratterizzato sempre da silenzi e cantato gospel mi infonde fiducia, la stessa che dovrei avere nel giorno nuovo che proprio ora mi preparo ad affrontare senza ore di sonno.
Notturno.