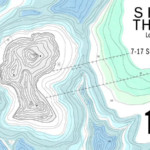Parafrasando le parole di Forster Wallace in Questa è l’acqua, nella nostra esistenza non c’è posto per l’ateismo: tutti adoriamo qualcosa, si tratta solo di scegliere cosa. C’è una credenza primaria – continua l’autore – che è destinata a diventare la nostra «configurazione di base»: che sia la fede in Gesù, in Buddha, nel potere o nel successo, questa sarà la lente d’ingrandimento attraverso cui filtrare la nostra esperienza.
Se pensiamo ad Agassi, Federer o Maradona, questi guerrieri della fatica hanno scelto invece lo sport come religione della propria vita; ed è proprio in quel tentativo estremo di superare i propri limiti – in quella ricerca della perfezione che si traduce in una disciplina ferrea, tesa verso un obiettivo che va al di là di se stessi – che si esprime quell’insopprimibile tensione dell’uomo verso la trascendenza, ragione per cui lo sport è l’esperienza più vicina alla spiritualità nel nostro tempo. Questo è l’assunto di base di un altro libro di D.F. Wallace, Il tennis come esperienza religiosa, che è anche punto di partenza per l’indagine su Discorso Celeste, terza tappa del progetto sui Discorsi che la compagnia d’avanguardia Fanny & Alexander porta avanti dal 2011.
Celeste perché è il colore del divino e della nazionale, un corto circuito di linguaggi che è visibile fin dall’inizio: Lorenzo Gleijeses, in tenuta sportiva, canta l’inno dell’Italia, ma come per interferenza questo è alterato da due motivi diversi, che sono i frammenti della radiocronaca della partita Italia-Germania del 1970 alternati a quelli del discorso di Papa Francesco ai catecumeni. Inizia subito dopo un dialogo tra l’attore e una voce fuori campo: un rapporto che è al contempo quello tra padre e figlio, Dio e adepto, tiranno e vittima, atleta e allenatore, giocatore e voce guida. L’impostazione infatti è quella di un videogame in cui l’atleta, avatar di sé stesso, deve superare vari livelli per poter accedere al grado di «Campione».

Foto ©Enrico Fedrigoli
«C’è un campo, tu e un avversario». La prima battaglia è quella contro sé stessi, ed ecco che una cortina trasparente nasconde l’attore mostrandoci solo la sua ombra che fa a pugni con un avversario immaginario—la sua paura. Quell’ombra minacciosa si connota così come un doppio di Gleijeses, forse la rappresentazione di tutti quei lati oscuri che deve lasciarsi alle spalle per poter aspirare al celeste del podio.
Game over: l’avatar a questo punto è pronto per risorgere e la voce a guidarlo attraverso ordini, istruzioni, frammenti della Bibbia, citazioni di Amleto e di Eduardo. L’attore esegue con scrupolosità ciò che gli è impartito, la sua fisicità scolpisce con forza un lavoro strenue sul corpo (movimenti di scena Marco Cavalcoli) che si sviluppa in una partitura fisica dove è mostrato lo sforzo di «saltare verso la fede», tappa fondamentale per poter proseguire nel gioco. Vedendolo viene in mente una frase di L’arte di correre di Haruki Murakami, dove lo scrittore-maratoneta afferma che è proprio nel superamento della fatica che si nasconde la sensazione autentica del vivere e che la qualità del vivere è insita nell’azione stessa. Il dispositivo dell’eterodirezione traduce in scena questa volontà di essere gettati nell’azione qui e ora, grazie ai comandi dettati dall’alto che permettono all’attore di «essere, non pensare».
Ma chi è davvero questa voce? È una guida benevola o un despota? C’è qualcosa che si è incrinato in questo rapporto padre-figlio: è ancora necessario «uccidere il padre» per consentire l’autoaffermazione di sé, oppure bisogna seguire i suoi ordini pedissequamente? Queste domande si caricano di ulteriori rimandi se pensiamo che la voce fuori campo in questione appartiene a Geppy Glejieses, padre di Lorenzo. Così, il problema risiede appunto nell’«essere o non essere», o meglio: come scegliere di essere ciò che si è? Se il passaggio dell’ombra del Padre è una tappa fondamentale verso la scoperta del proprio sé, dove finisce questa e dove inizia l’autonomia dell’individuo? E che succede se quell’ombra non è mai superata ma rimane sempre lì, a ricordarci della nostra dipendenza da essa?
In un padre e un figlio che svolgono la stessa professione, poi, è una questione dai contorni ancora più sfocati: si pensi al rapporto tra il campione Agassi e suo padre, ma gli stessi Geppy e Lorenzo Gleijeses – entrambi attori – esempio in cui la metafora sportiva sfocia in quella teatrale, come è evidente da una piccola incursione in cui padre e figlio provano un vecchio spettacolo che avevano messo in scena davvero qualche anno fa. Sembra quasi che l’attore corrisponda ad un «atleta della scena», considerata la lotta verso il superamento dei propri limiti che è anche prerogativa di chi vuole calcare la scena.

Foto ©Enrico Fedrigoli
Nel finale, l’attore approda in un «paradiso» che prende le sembianze di un medaglione video a forma di cerchio. Ora finalmente il figlio può ricongiungersi al padre e allunga la mano verso il pubblico, quasi fino a toccarlo. Ma cosa vuol dire questa unione, visibile solo in 3D e quindi già di per sé impossibile nella realtà? È un pacifico patto di unione tra il figlio e il padre “evaporato”, o un definitivo soccombere alla sua volontà?

Foto ©Enrico Fedrigoli
Fanny & Alexander non forniscono una risposta in Discorso celeste, il loro compito è sfidare le percezioni sensoriali degli spettatori e catapultarli in una realtà virtuale, grazie alla creazione di immagini oniriche e di grande impatto visivo. È un’atmosfera resa possibile grazie al dialogo tra i testi di Chiara Lagani, la regia visionaria e le luci di Luigi De Angelis, la musica elettronica di Mirto Baliani e le immagini video di Zapruderfilmmakersgroup, tutti elementi semantici di uguale dignità e materiale drammaturgico complesso, la cui efficace compenetrazione fa scaturire una serie di domande che si accavallano l’una sull’altra.
Concludendo ancora con D.F. Wallace, una cosa certa è che ognuno porta dentro di sé la propria configurazione di base, un filtro che elimina tutti gli altri esponendoci per forza di cose ad una visione parziale della realtà. Tutti seguiamo le nostre istruzioni, i nostri ordini e siamo inconsciamente «eterodiretti». Ma le istruzioni da chi sono dettate: da noi stessi o dall’esterno? Alla compagnia ravennate la domanda, a noi cercare la risposta.
Angelo Mai, Roma – 10 aprile 2015